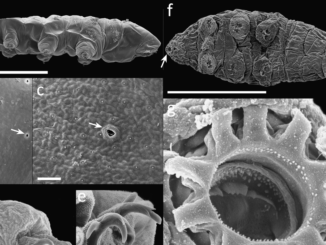Il 16 settembre Mickey Rourke compie 70 anni. Qualche giorno fa lo accennavo a un giovane studioso di cinema. Gli anticipavo che volevo scriverci sopra un pezzo, partendo dalla considerazione che Rourke è sempre stato un attore sottostimato e che le sue interpretazioni degli anni ’80 resistono al tempo per qualità e raffinatezza. Lui ha commentato laconico: sì, credo di sì, e io: beh, ma tu eri piccolo, non puoi ricordare. Ebbene, mi sono reso conto che l’amico non poteva ricordare nulla perché credo sia nato a ridosso degli anni 2000, quindi tutto un altro scenario, un’altra esperienza diretta della settima arte rispetto alla mia. Quantomeno non deve aver vissuto di persona i centri storici ancora pieni di sale, né per esempio la (non esaltante) epoca delle videocassette.
In effetti scrivere di Rourke, evitando le facili speculazioni sui suoi ricorrenti e grotteschi tentativi di chirurgia facciale, pare anche a me un esercizio piacevolmente fuori moda. Parafrasando la struggente frase di Randy “The Ram” nel finale di “The wrestler”, potremmo dire che “al mondo non frega un cazzo di lui”.
Invece vorrei scriverne perché i grandi attori – ce ne sono di tutti i tipi, beninteso, quindi non solo star nordamericane, ma presenti (seppur in numero limitato, perché il talento è sempre raro) in tutti gli angoli del mondo, in tutti i palcoscenici teatrali e in tutte le cinematografie – dicevo i grandi attori, attraverso le loro performance, i loro personaggi, la loro arte possono essere fonte di ispirazione per le vite di ognuno di noi.
La recitazione di Rourke assurge ad arte perché è complessa, piena di sfumature, mai ordinaria, organica e va (quasi) sempre a segno. “È un virtuoso actor”, scrive di lui Anthony Hopkins in uno scritto autobiografico, “e io mi dovetti preparare a fondo per essere all’altezza in “Ore disperate” di Michael Cimino.” Che lo dica Hopkins, attore ultra stimato e celebrato, non è un caso. Chi si misura con i ciak e i set, riconosce la qualità. Per di più “Ore disperate” (Desperate hours, 1990), remake del film con Humphrey Bogart (1955), è oggettivamente un film assai debole, ma questa è una costante della carriera di Rourke: far parte di film mediocri e riuscire ad essere la parte migliore di quel film.
C’è molta verità anche nella frase provocatoria che Vincent Gallo pronunciò anni fa: “nella sua peggiore interpretazione Rourke è comunque meglio di Sean Penn al suo meglio”. Non si tratta qui di indugiare sui paragoni: Sean Penn è un attore molto ben inserito, anch’egli celebrato e premiato, e non c’è dubbio che esprima una passione reale verso la professione. Tuttavia è impossibile non esprimere un rammarico profondo quando nel 2009 Penn vinse il suo secondo Oscar come miglior attore per “Milk”, con un’interpretazione più scolastica e prevedibile rispetto all’intensità di Rourke in “The wrestler”, ma la suggestione di Gallo è importante perché ci riporta proprio agli anni ’80, quando una nuova generazione di attori prendeva campo dopo quella degli anni ’70. Intendo dire che William Hurt, John Malkovich, Willem Dafoe, Johnny Depp, Rourke, Penn, ma anche Kevin Costner e Nicholas Cage, piano piano davano il cambio (ci provavano perlomeno, con alterne fortune e talento diseguale) ai fenomeni dalle ‘facce qualunque’: Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Al Pacino e Robert De Niro. Tra tutti i nomi che ho fatto, negli anni ‘80 Rourke è sempre rimasto fuori dal giro dei premi e anche, per la verità, dei grandi registi. Forse il caso, oppure scelte sbagliate: per produttori e registi anche la consapevolezza che Rourke non fosse mai ordinario, piuttosto una star faticosa da gestire.
Un po’ di biografia. Rourke nasce a New York nel 1952. Qualcosa va storto tra i suoi genitori e quando ancora è piccolo si trasferisce con la madre a Miami dove cresce in una condizione (lo si intuisce dalle sue dichiarazioni e interviste) piuttosto infelice: viene frequentemente picchiato dal patrigno, il nuovo compagno della moglie. A scuola non funziona, l’unica cosa che lo ‘salva’ da cattive compagnie è la palestra di boxe. La pratica del pugilato è davvero un potente appiglio nella sua vita spericolata, tanto che segnerà l’assurda scelta (assurda sì, ma con qualcosa di puro e di eroico, perché fuori da ogni convenienza) di piantare la carriera e rimettersi a boxare da professionista a 40 anni. Il giovane Rourke diventa un atleta nei suoi teens, e in fondo questa attitudine all’esercizio quotidiano del corpo – che negli attori di Hollywood si manifesta spesso con una volgarità assoluta, nel senso che passano il tempo a rimirarsi i muscoli allo specchio invece che a studiare – nel caso del nostro attore appare onesta e naturale. Debutta sul ring, fa qualche incontro, poi prende subito qualche pugno di troppo e un medico gli impone di smettere per un accenno di commozione cerebrale.
Cosa fa Rourke? Va a New York e prova a studiare teatro. Ci prova con la stessa dedizione di un boxeur, nel senso che sul ring il responso è crudo: non puoi raccontarla, non puoi bluffare. E così nella recitazione. Anzi, per la verità il suo è un approccio molto idealista: studia a fondo e vedrai che il talento si irrobustirà e qualcuno lo valorizzerà.
Entra all’Actors Studio (ecco perché è un virtuoso actor, nonostante tenda a schernirsi e presentarsi come un totale outsider) ed Elia Kazan loda la sua prova d’ingresso come “la migliore audizione degli ultimi trent’anni”. Dire Kazan equivale a evocare il trio delle meraviglie della recitazione cinematografica americana del ‘900: Marlon Brando, Montgomery Clift e James Dean.
Questo periodo di studio ha molto a che fare con la disillusione profonda verso il lavoro dell’attore che Rourke proverà a partire dalla metà degli anni ’80: Mickey è uno che ci crede e che, nonostante il suo understatement nelle interviste, conosce a fondo la recitazione e si accorge ben presto con disappunto che al cinema può figurare bene anche un cane. Perfino un Tom Cruise.
Questi sono i suoi anni ’70. Che oltre al teatro comprendono un apprendistato davanti alla macchina da presa fatto di film per la televisione, con parti sia piccole che principali. Alcuni di questi prodotti si rintracciano online, su Youtube per esempio. C’è un Rourke molto giovane, ma subito si coglie una sua caratteristica: il modo di muoversi ed esprimersi non è mai convenzionale. È sempre un po’ trasversale, sfuggente. Tutto questo in un contesto, quello televisivo, che per sua natura costringe l’attore a una uniformità espressiva.
Non vale solo per Rourke, ma guardare a ritroso le prime prove di un grande attore è sempre affascinante: di norma ci trovi già il germe di una maestria.
Di lui Alan Parker ha detto che se fosse morto subito dopo la realizzazione di “Angel heart” sarebbe diventato un mito assoluto, ai livelli di James Dean. Anch’io lo trovo credibile. Sempre a proposito di “Angel heart”, lo stesso regista inglese disse che Rourke era sempre sorprendente in ogni ciak, a differenza dei colleghi, anche i più bravi, tanto da offrirgli tutta una gamma di soluzioni in fase di montaggio. L’incontro con Robert De Niro, un suo modello di riferimento, soprattutto per l’amatissimo film “Il cacciatore” (The deer hunter), fu un disastro. De Niro all’epoca era in una fase particolare: dopo una carriera da autentico mito, si sperimentava in cameo di qualità, come Al Capone ne “Gli Intoccabili” di Brian De Palma, il folle Tuttle in “Brazil” di Terry Gilliam e appunto Lucifero nel film di cui parliamo. Siccome impersonava il diavolo, Bob disse a Rourke che non poteva avere alcun tipo di rapporto con lui, al di fuori delle scene del film. Una presa di distanza quantomeno maniacale e a Rourke questa freddezza umana non piacque. Ogni loro ciak divenne una sfida, un duello per vedere chi era più bravo. In effetti le loro sono scene seducenti, come l’intero film del resto. Che uscì e venne recensito malissimo, e andò male anche al botteghino negli Usa, per via dei divieti dovuti alle scene di sesso con Lisa Bonet. Col senno di poi, molti (tra questi anche il sottoscritto) pensano che Rourke avrebbe meritato l’Oscar. Ovviamente non venne neanche preso in considerazione.
Ma sono tanti i film rourkiani che sono underestimated: l’Henry Chinaski di “Barfly” (1987, regia di Barbet Schroeder) è davvero notevole con un lavoro di grande credibilità su movenze e voce, peraltro un film girato da totale astemio, in contrasto con il climax alcolico della vicenda e del personaggio. Lo stesso Bukowski, dapprima scettico, si proclama stupito della bravura di Rourke nel suo bel libro (“Hollywood Hollywood”), dove un ritratto credibile dell’attore viene reso sotto il nome di Jack Bledsoe.
Il fatto è che, nonostante si sia sempre intelligentemente schernito, Rourke si è preparato ogni volta con grande abnegazione per un ruolo. Basti pensare a quanta preparazione fisica abbia richiesto “The wrestler”: un’interpretazione che forse avrebbe potuto meritare anche una sceneggiatura più articolata, meno ‘favoletta’.
Torniamo alla filmografia. Rourke ottiene le sue prime piccole parti in “1941 – Allarme a Hollywood” di Steven Spielberg, “I cancelli del cielo” di Michael Cimino e “Brivido caldo” di Lawrence Kasdan. Dei tre, il più seminale è il secondo, quello con Cimino, perché sul regista italoamericano Rourke ripone una fiducia assoluta. E perché gira le scene con Christopher Walken, altro riferimento che gli sarà sempre amico. Diretto da Cimino Rourke girerà da protagonista “L’anno del dragone” (Year of the Dragon, 1985) con un’interpretazione molto solida, forse persino un po’ manieristica. Nel senso che in ogni fotogramma Rourke è interessante e credibile, terribilmente cool, ma il suo virtuosismo si spinge a livelli più da personaggio che da persona. È in fondo una qualità, infatti anni dopo Rourke sarà l’anima di un film come “Sin city”, con sembianze generosamente irriconoscibili.
Ma prima ancora arriva “Diner – A cena con gli amici” (1982) di Barry Levinson, un film corale pieno di giovani attori che faranno strada, ma Rourke ha già 30 anni, invece dei loro 20, e ritaglia un personaggio magistrale, premiato questa volta con il National Society of Film Critics Award come miglior attore non protagonista. Poi arriva “Rusty il selvaggio” (Rumble fish, 1983) di Francis Ford Coppola dove Rourke è una presenza misteriosa e seducente, e recita accanto a Dennis Hopper e Matt Dillon (e Diane Lane, Cage, Chris Penn, Fishbourne e Tom Waits). Per chi scrive, questo è già un film da vedere più volte, non fosse anche solo per le musiche di Stewart Copeland.
Poi viene fuori un progetto a cui tenevano molto Pacino e De Niro per lavorare insieme in un film, anni prima di “Heat”: ovvero “Il papa del Greenwich Village” (The Pope of the Greenwich Village, 1984, regia di Stuart Rosenberg). Alla fine il film si fa, ma con i ben più giovani e sconosciuti Rourke ed Eric Roberts. Di nuovo, in fatto di premi, sia per “Rumble fish” che per “The Pope”, Rourke avrebbe potuto benissimo figurare agli Oscar nella cinquina dei migliori attori non protagonisti.
Poi arriva “Nove settimane e mezzo” (9½ Weeks, 1986, regia di Adrian Lyne) , anche questo un enorme successo in Europa, ma niente di tutto questo in America. Il film venne relegato a fenomeno di cassetta, senza alcun riconoscimento autoriale ed è un peccato perché la performance di Rourke è certamente di grande magnetismo.
Poi ci sono “Angel heart”, di cui abbiamo già scritto, pur nella consapevolezza che meriterebbe ben altro spazio, e “Barfly”. E ancora “Homeboy”, un film che è lo stesso Rourke a scrivere, con venature autobiografiche (il protagonista è un pugile). È l’interpretazione che Bob Dylan semplicemente adora, tanto da parlarne nella sua autobiografia “Chronicles vol. 1”. Purtroppo però ormai la critica e l’establishment ha relegato Rourke su un piano di scherno e diffidenza. A prevalere sono attori francamente più “ordinary”, a prevalere è, perdonate l’insistenza, Tom Cruise.
Gli anni ’80 si chiudono con “Johnny il bello” (Johnny Handsome, 1989), un bel film di Walter Hill, con “Francesco” di Liliana Cavani dove si sperimenta un Rourke notevole a dispetto dell’opera non eccelsa (seppure in questo caso sia impossibile accettare un san Francesco palestrato), e con il mediocre “Orchidea selvaggia” che a Rourke procurerà notevoli guai personali per via della relazione (tossica per entrambi) con Carré Otis.
Qui finiscono gli anni ’80, Rourke ricomincia a boxare per qualche anno, poi tornerà al cinema che è tutt’ora ciò che gli procura da vivere.
Permettetemi di avviarmi alla conclusione con quattro brevi approfondimenti.
La voce. Ci sono due fasi della carriera di Rourke: prima e dopo il ritorno alla boxe, potremmo dire. Ma ce n’è almeno un altro: la voce. La voce di Rourke è cambiata all’improvviso in modo misterioso. In tutta la prima parte della carriera ha una voce molto morbida, gentile, sottile. È così in “Rusty il selvaggio”, in “L’anno del dragone”, in “Nove settimane e mezzo”, ed è bellissima, perché inaspettata. Paragonate quel timbro alla voce cavernosa e profonda in “The wrestler”, beh, sono due persone diverse. Non ho idea di come si possa cambiar voce. Di certo non è una questione di fumo e alcol, alla Tom Waits, tra l’altro Rourke è un salutista, magari non ossessivo, ma sa bene che il corpo va tenuto in salute.
Le lacrime. Rourke piange spesso nei suoi film, perlomeno con una frequenza decisamente inusuale per una star: ovviamente piange perché lo richiede la sceneggiatura, ma io credo anche che lo faccia semplicemente molto bene, e che sia difficile farlo bene. Uno dei segreti sta nella tecnica, nell’intenzione: quando Rourke piange, l’azione non è (come si potrebbe credere) sforzarsi di farsi venire fuori le lacrime, quanto piuttosto cercare di fermare il pianto, di nasconderlo, esattamente come accade nella vita. Perché quasi sempre ci imbarazza farci vedere piangere.
“The wrestler”. Torniamo a questo film solo per dire che non si è trattato semplicemente di un coming back, ovvero della riscoperta, che peraltro si è esaurita in fretta, di un grande attore, ma ciò che colpisce è come Rourke riesca in quel film a toccare corde, a esprimere una condizione come non ne avevamo viste in precedenza. C’è una naturalezza, un livello di accettazione della vita da parte di Randy “The Ram” che è assolutamente commovente. Ma ciò che più conta, questo è un attore che non si adagia sul repertorio dei gesti, sul bagaglio espressivo, e continua a lavorare, a scavare, a trovare.
Le occasioni mancate. Spesso Rourke ha rifiutato una parte in modo scriteriato, o semplicemente poco fortunato. Per esempio doveva essere in “Pulp Fiction”, al posto di Bruce Willis, ma quando arrivò la proposta di Tarantino era ancora nel pieno della sua rinascita pugilistica e non voleva mollare il suo regime di training. Ma c’è anche uno spiacevole episodio che riguarda il taglio della parte di Rourke al montaggio. Parliamo de “La sottile linea rossa” di Terence Malick: il grande regista operò diversi tagli, cancellando metri e metri di ‘girato’ in un modo talmente disinvolto da restare leggendario (ma non è questo il focus dell’articolo). La scena con Rourke è disponibile in rete e appare davvero di un’intensità speciale. Credo, e così mi professo estimatore assoluto dell’attore, che avrebbe reso ancor più epocale quel film.
Happy 70th, mister Rourke!
di Francesco Rossetti